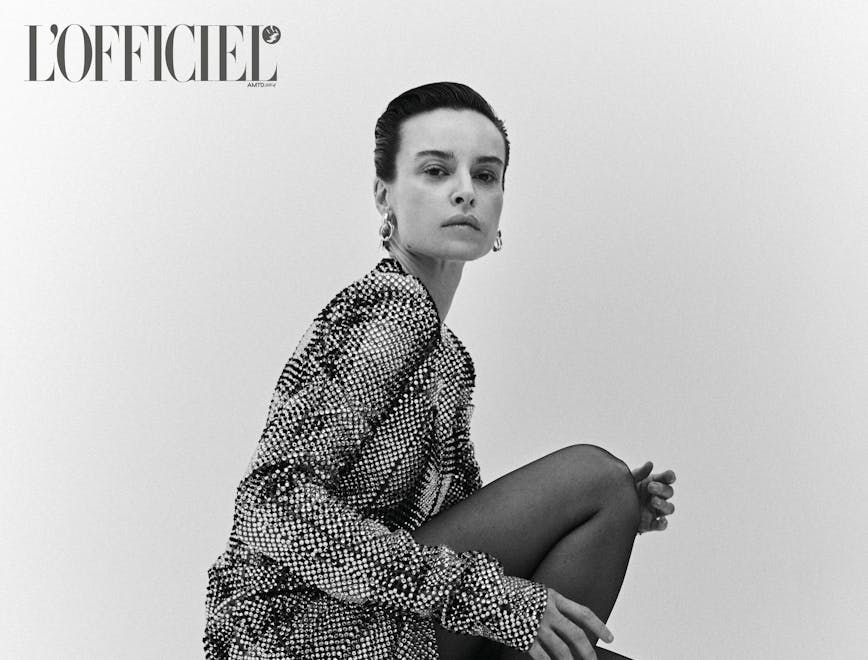"War on Education" documenta la distruzione delle scuole ucraine voluta dal Cremlino
Nelle sale dal 24 febbraio, il documentario di Pietro Di Stefano racconta il tentativo russo in tre anni di guerra di distruggere sistematicamente asili, scuole, biblioteche ucraine, nel tentativo di cancellarne la cultura.
Attraverso riprese negli oblast ucraini colpiti dal conflitto, da Cherson a KyIv, e immagini di luoghi emblematici di Mosca sotto la neve, dal Museo della Grande Guerra Patriottica al Muro del Dolore, il regista Pietro Di Stefano raccoglie le testimonianze dell'attuale ministro dell'istruzione ucraino Oksen Lisovyi, del reporter per il Kyiv Independent Alexander Khrebet, della portavoce dell’Unicef Emmanuelle Abrioux, di insegnanti e accademici, per raccontare l’attacco sistematico alle istituzioni educative e al patrimonio artistico-culturale perpetrato dall’inizio dell’invasione russa, partendo dal presupposto che l’istruzione è diventata un terreno di scontro strategico in una guerra ibrida, in cui la distruzione delle scuole e la riscrittura della storia diventano strumenti di dominio e cancellazione dell’identità nazionale, perchè come sottolinea Lisovyi: “L’educazione dà forma al domani”. Dopo 3 anni di guerra, secondo i dati del Ministero dell’Educazione e della Scienza ucraino, oltre 3 mila strutture educative - dagli asili alle università - sono danneggiati o distrutti, circa due asili su tre sono chiusi, e ogni bambino a 50 chilometri dal fronte non ha accesso ad alcuna forma di educazione, per ovvi motivi di sicurezza. Mentre dall’inizio del conflitto sono oltre 20 mila i bambini ucraini deportati in Russia, dove la loro crescita ed educazione è soggetta a percorsi di apprendimento della storia russa all’interno dei quali l’esistenza della cultura e dell’identità ucraina non è contemplata.
"Per raccontare la devastazione del sistema educativo ucraino sotto i bombardamenti e l'occupazione, ho adottato un linguaggio filmico che predilige l’immersione totale dello spettatore nella realtà del conflitto- spiega Di Stefano.- La camera è stabile, i movimenti sono lenti e misurati, quasi a voler restituire il peso e la gravità di ogni momento. La scelta di utilizzare numerosi close-up nasce dall’esigenza di avvicinarsi il più possibile ai volti e agli sguardi di studenti, insegnanti e famiglie, scandagliando la loro paura, la loro resistenza e la loro speranza. In un contesto in cui le parole spesso non bastano, sono gli occhi e i silenzi a raccontare la storia”. "Il mio obiettivo è stato quello di far sentire lo spettatore parte di questa tragedia, non come semplice osservatore, ma come testimone attivo di una guerra che non colpisce solo le infrastrutture, ma la coscienza stessa di un popolo”. Come sottolineano gli accademici intervistati, la politica di cancellazione della cultura ucraina e di russificazione forzata non è un’invenzione di Putin, ma ha radici antiche di 300 anni, ha raggiunto lo zenith nel 1863, all’epoca dello zar Alessandro II, quando decreti ministeriali sancivano che “la lingua ucraina non esiste e non è mai esistita”, ed è proseguita coi libri di storia russa degli ultimi 20 anni, dove la storia degli ucraini è presentata come storia russa. Come racconta Tamara Bidelman, storica russa dissidente ed ex insegnante di storia, in Russia si è tornati al libro unico di storia come ai tempi dell’URSS, che era stato abolito nel 1988. Ed è così che studia il milione di ucraini tra i 6 e i 17 anni che frequentano oggi le scuole nelle zone del Paese, come la Crimea, controllate dall’esercito russo.